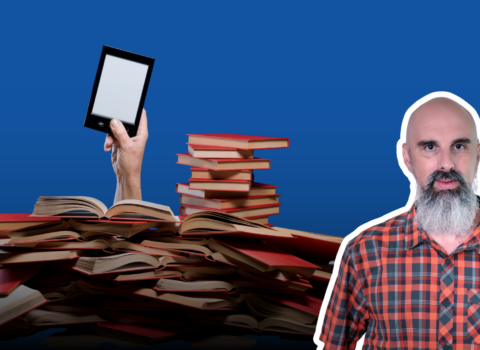
Noi abbiamo vissuto la bomba atomica. I gesuiti di fronte alle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki
Ottant’anni dopo Hiroshima, la riflessione sulla bomba atomica resta cruciale per comprendere il rapporto tra scienza, potere e responsabilità etica. L’esperienza diretta dei gesuiti sopravvissuti all’esplosione aiuta a interrogarsi sul significato umano e morale dell’uso dell’energia nucleare in guerra.
Quando la prima bomba atomica a uso bellico della storia cadde su Hiroshima il 6 agosto 1945, il gesuita basco Pedro Arrupe – futuro Superiore Generale dell’ordine – si trovava nel noviziato di Nagatsuka, a pochi chilometri dall’epicentro. La sua testimonianza descrive con drammatica precisione l’istante dell’esplosione, evidenziando l’impossibilità di rappresentare quanto stava accadendo secondo le categorie note. Ci furono una luce accecante, un boato innaturale, e poi il silenzio, carico di orrore. Saliti su una collina, i gesuiti scoprirono una città cancellata: dove un giorno c’era vita, ora non restavano che fumo, fiamme e macerie. Da questo scenario impensabile si muovevano i sopravvissuti, alla ricerca di cure, relazioni, conforto.
Nei giorni seguenti, il noviziato divenne un rifugio per i sopravvissuti. Arrupe, medico di formazione, si trovò ad affrontare ferite mai viste prima: ustioni che si manifestavano ore dopo l’esplosione, corpi apparentemente illesi che crollavano senza motivo, sintomi di un male invisibile – le radiazioni – allora sconosciuto alla scienza. Senza medicine né attrezzature adeguate, i religiosi poterono offrire solo cure elementari e conforto spirituale. La scelta consapevole fu quella di disinfettare le piaghe e di cercare cibo, sperando che la natura avesse la forza di aiutare i corpi feriti: Arrupe parla di ipernutrizione. In parecchi casi funzionò. Celebrarono messa tra le macerie, e Arrupe, nelle sue memorie, ricordò la preghiera per i responsabili del bombardamento, un atto di perdono evangelico: «Perché non sanno quello che fanno». Ma in quelle parole risuonava una dissonanza tragica: il presidente Truman e gli scienziati guidati da Oppenheimer sapevano cosa avevano scatenato.
Johann Siemes, gesuita tedesco e testimone oculare accanto ad Arrupe, pose sul Time (febbraio 1946) la domanda morale inevitabile: «In una guerra totale, l’uso di tali armi può mai essere giustificato?». Le risposte non furono unanimi. Mentre il mondo iniziava a interrogarsi, i gesuiti della rivista America Magazine provarono a rispondere nell’editoriale del 18 agosto 1945, dipingendo scenari apocalittici di un’umanità costretta a vivere sottoterra e lanciando un monito profetico sulla proliferazione nucleare.
A ottant’anni di distanza, quelle testimonianze conservano una pressante attualità. Non sono solo memoria storica, ma un invito pressante a ripensare il nostro rapporto con le armi di distruzione di massa. La testimonianza dei gesuiti degli anni Quaranta ci mostrano che, di fronte all’apocalisse nucleare, esistono solo due strade: la rassegnazione alla violenza o la scelta coraggiosa di costruire una pace giusta. La loro lezione è chiara: finché esisteranno armi atomiche, nessuno potrà davvero dirsi al sicuro. Ottant’anni dopo, la scelta tra la paura e l’impegno per un mondo libero dal nucleare rimane una sfida urgente per l’umanità intera.




