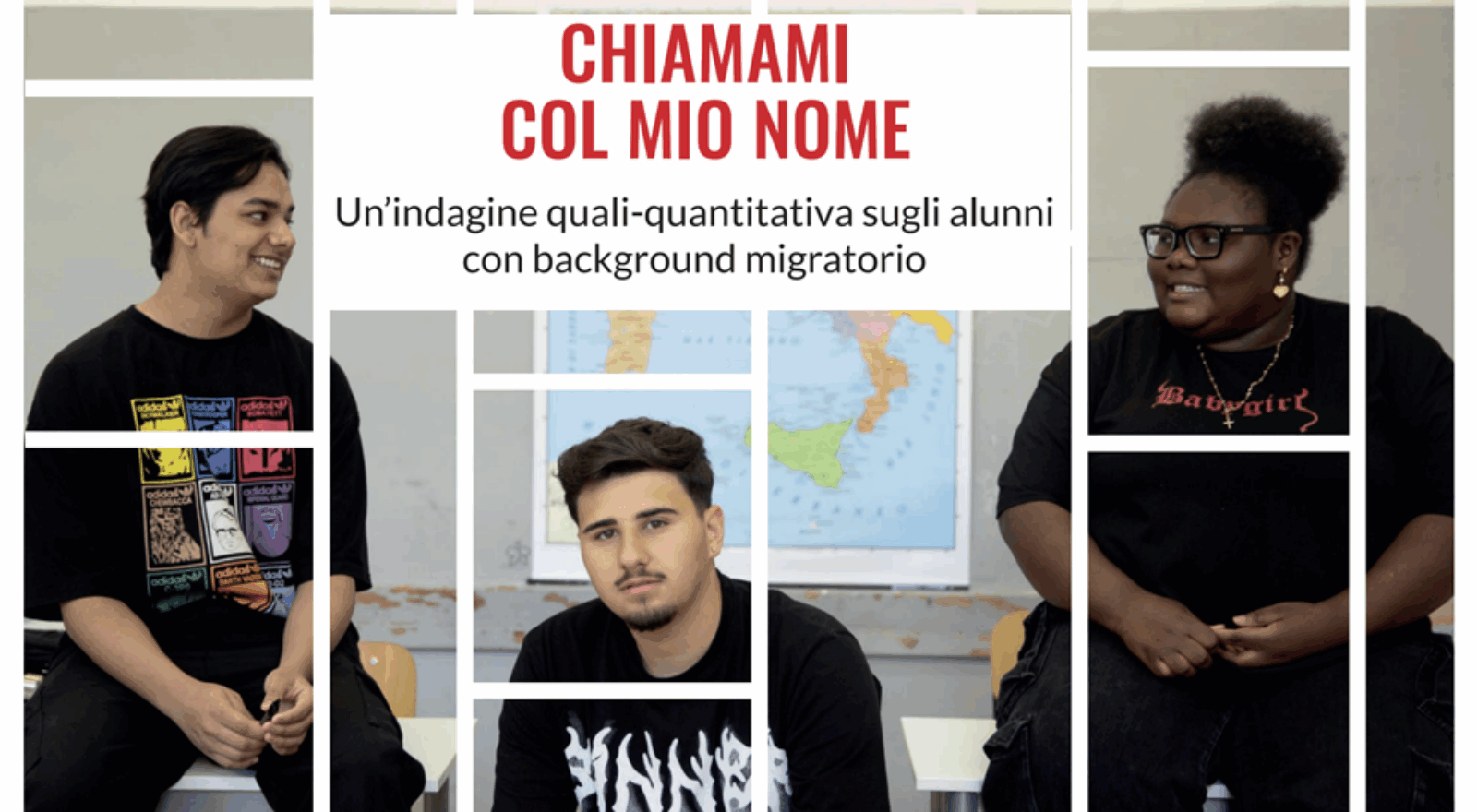“Chiamami col mio nome”
Il Centro per le Scienze Religiose FBK ha collaborato come partner di ricerca al Dossier Back to School 2025 di Save The Children che analizza la condizione dei giovani con background migratorio in Italia. Per approfondire abbiamo fatto alcune domande alla ricercatrice FBK-ISR Valeria Fabretti
Quale è stato il vostro obiettivo nella realizzazione del dossier Back to School 2025 di Save The Children dal titolo “Chiamami col mio nome” dedicato alle ragazze e ai ragazzi con background migratorio?
Abbiamo colto con entusiasmo l’occasione di partecipare al progetto Back to School nella convinzione che lo studio delle traiettorie delle ragazze e dei ragazzi con background migratorio rappresenta uno strumento di analisi essenziale sulla società, permettendo di svelare meccanismi di discriminazione ma anche processi di trasformazione, che sfidano etichette semplicistiche e concezioni ingessate delle identità.
Il Centro FBK-ISR è stato protagonista di questo lavoro. Quale è stato in praticolare il ruolo svolto?
Come Centro per le Scienze Religiose di FBK – in un piccolo team composto da me e da Stefania Yapo – abbiamo collaborato con le ricercatrici e i ricercatori di Save the Children Italia e con attiviste/i del movimento Italiani Senza Cittadinanza impegnate/i nel progetto “Back to School”, ideando e realizzando il segmento di ricerca qualitativo. Attingendo alle sensibilità e alle competenze presenti nel nostro Centro, abbiamo seguito una prospettiva sociologica e dato un’attenzione particolare ad alcuni aspetti dei processi di esclusione/inclusione sociale, largamente oggetto delle nostre riflessioni, come le forme di discriminazione intersezionale e le sfide del riconoscimento dei gruppi culturali e religiosi di minoranza. Abbiamo quindi lavorato alla raccolta delle interviste – incontrando le ragazze e i ragazzi durante l’orario scolastico nelle tre città -, all’analisi dei dati e, successivamente, alla stesura di testi che sono andati a comporre il Dossier “Chiamami col mio nome” appena uscito. Una pubblicazione curata da me e da Christian Morabito, ricercatore di esperienza per Save the Children Italia che ha condotto l’indagine di tipo quantitativo.
Che metodo di ricerca avete seguito?
Entrare nella ricerca ha richiesto certamente uno sforzo di tipo metodologico, perché in un’ampia elaborazione di dati di tipo quantitativo abbiamo innestato un segmento di ricerca qualitativo, volto a dare profondità allo studio e ad aprire una finestra sul caso specifico dei giovani nati e/o cresciuti in Italia. In questo approfondimento, oltre che raccogliere il punto di vista di alcuni insegnanti, educatori e operatori del sociale riguardo alle sfide dell’inclusione, abbiamo scelto di intervistare studentesse e studenti frequentanti il primo e il quinto anno di scuole secondarie superiori con diverso indirizzo nelle città di Brescia, Modena e Trento (27 in tutto). Pur nella loro diversità, infatti, le tre città presentano caratteristiche simili, come la distribuzione della popolazione migrante, che permettono, in una investigazione di dimensioni limitate, l’adozione di comuni domande di ricerca. Attraverso la voce di queste ragazze e questi ragazzi, nati e/o cresciuti in Italia da famiglie migranti, abbiamo potuto riconoscere alcuni aspetti centrali della loro esperienza, che motivano le scelte che hanno intrapreso e il modo in cui guardano al futuro.
Quali sono i principali risultati emersi dallo studio?
Mentre l’analisi dei dati ISTAT, MUR e INVALSI ha aggiornato il quadro relativo alle persistenti disuguaglianze che interessano le studentesse e gli studenti con background migratorio rispetto ai cosiddetti “nativi” all’interno del percorso scolastico – ad esempio in termini di scelte tra i diversi indirizzi della scuola secondaria superiore, di esiti (successo/insuccesso) e delle aspettative nei confronti del proseguimento degli studi in ambito universitario –, la fotografia che emerge dal nostro lavoro qualitativo è più sfumata. A livello sociale, le ragazze e i ragazzi “di seconda generazione” sviluppano forme di identità plurali, mantenendo spesso un legame forte – considerato una risorsa anche quando vissuto in modo critico – con le culture del Paese di provenienza dei loro genitori; culture che vorrebbero vedere riconosciute come parte di un panorama italiano sempre più plurale, anziché come elementi estranei, spesso sviliti nei dibattiti pubblici e nei contenuti proposti da vecchi e nuovi media. Consapevoli del più generale clima ostile che investe la figura del “migrante” – specie in alcune intersezioni, ad esempio con la figura del “musulmano” – questi giovani sperimentano sì episodi di razzismo in forma latente o esplicita, ma sembrano saperli affrontare con autocontrollo e talvolta persino con ironia. Emergono così anche le loro risorse, spesso rafforzate dallo sprone famigliare ad evitare il conflitto e a investire nell’integrazione per assicurarsi una “vita buona”. Con il rischio, però, che dinamiche escludenti, radicate soprattutto nelle generazioni adulte, vengano “normalizzate” e sfuggano ad una elaborazione collettiva, ad esempio nei contesti educativi.
Emergono anche i limiti del sistema scolastico italiano, specie in alcuni passaggi-chiave, come quello dell’orientamento alla scelta della scuola superiore. In questa fase, alcune pre-concezioni – possiamo dire alcuni bias – sembrano guidare i consigli orientativi prodotti dalla scuola secondaria di primo grado, ancora oggi tendenti a disincentivare nei giovani con origine migratoria la scelta di alcuni indirizzi a favore di altri, indipendentemente dal loro andamento scolastico e dalle loro preferenze.
Infine, avere o meno la cittadinanza italiana sembra fare una differenza: in grado di ridurre i gap in termini di apprendimento e scelte rispetto ai coetanei senza background migratorio, la cittadinanza è anche vissuta come una condizione di legittimità sociale e una base giuridica e simbolica per progettare il proprio futuro, anche in termini di mobilità.
Nel complesso che cosa si può concludere ?
Nel complesso, possiamo dire che i percorsi sociali e educativi non solo dei giovani arrivati di recente nel nostro Paese ma anche di quelli nati e/o cresciuti in Italia non sono ancora equiparabili a quelli dei loro coetanei senza background migratorio. E non si tratta solo di una “questione di tempo”. Occorre rimuovere gli ostacoli verso il loro pieno accesso ai servizi e diritti fondamentali, e predisporre situazioni che valorizzino le loro stesse risorse e forme di partecipazione, anche in qualità di cittadine e cittadini. La scuola è in prima linea, come spazio per la costruzione del senso, la promozione dell’uguaglianza e la lotta alle discriminazioni. Ma deve essere inserita in reti capaci di supportare e adattare l’intervento educativo ai bisogni emergenti nei diversi contesti.
Come era nata la collaborazione con Save The Children ?
Quella tra FBK-ISR e Save the Children Italia è una collaborazione ormai di lunga data, che ha visto in quasi dieci anni la firma di diversi accordi di ricerca– l’ultimo, inerente questo studio, siglato in aprile 2025 – sulla base del comune intento di far dialogare ricerca e intervento sociale. In FBK-ISR come nella Fondazione in generale, diversi progetti, pur adottando approcci di studio specifici e rigorosi, ricercano ricadute a livello di impatto sociale; allo stesso tempo, negli ultimi anni Save the Children Italia ha potenziato la sua componente di ricerca, instituendo un Centro interno specificamente dedicato. È segno che, di fronte a scenari sociali complessi come quelli che ci si presentano oggi in diversi campi, sia la comprensione dei fenomeni che la loro trasformazione richiedono nuove alleanze e l’incontro di prospettive diverse, capaci di arricchirsi a vicenda. In questa occasione, la collaborazione si è allargata all’associazione Italiani Senza Cittadinanza, movimento auto-organizzato composto da “figlie e figli di immigrati”, che ha portato nel progetto le esperienze, le competenze e le proposte delle e dei giovani impegnati da tempo nella sensibilizzazione verso l’acquisizione della cittadinanza italiana e per il miglioramento della legge che la regola, la legge 91 del 1992. Questo terzo elemento si è rivelato prezioso sia nella costruzione delle domande di ricerca che nell’interpretazione dei risultati, convincendoci ulteriormente della necessità per la ricerca di aprirsi alla contaminazione con le componenti della società civile che rappresentano i gruppi sociali cui ci accostiamo.
Quali sono le prospettive future?
Il futuro è senz’altro aperto a nuove collaborazioni con Save the Children Italia, con cui stiamo anche portando avanti alcune proposte progettuali per bandi competitivi a livello europeo su ulteriori temi di comune interesse e impellenza sociale. Tra questi, le sfide che interessano l’educazione e la formazione dei giovani nella società dell’Intelligenza Artificiale e il rapporto tra l’avvento di quest’ultima e le disuguaglianze educative.
Cover: Save the Children_ph Lorenzo Pallini per Save the Children