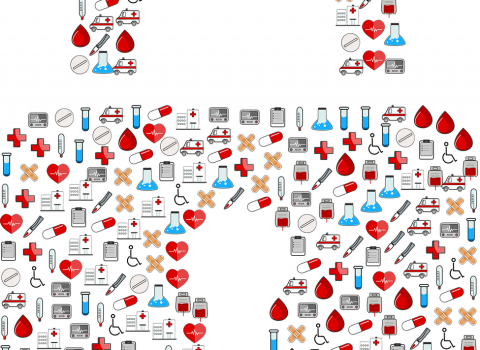Trasformare i numeri in storie di vita: l’esigenza di commemorare le morti durante la pandemia di Covid
Una riflessione per ridare dignità alle morti solitarie della pandemia
Nel triste giorno in cui l’Italia ha raggiunto i 100.000 decessi da inizio pandemia (su un totale di 2,5 milioni nel mondo) FBK per la Salute ha organizzato un webinar in cui la dott.ssa Marina Sozzi ha offerto una toccante riflessione su cosa è stato ed è morire di covid per il malato, i familiari e i medici che forniscono fino all’ultimo assistenza.
Paradossalmente, affrontare la morte è un modo per scoprire la vita. Ci fa uscire a forza dal nostro guscio di narcisismo e presunta onnipotenza terrena in cui ci siamo rinchiusi negli ultimi decenni, confortati dagli enormi progressi di una medicina sempre più capillare e all’avanguardia. A noi che credevamo di morire anziani, circondati dall’affetto dei nostri cari, seguendo un naturale percorso sereno di accompagnamento al fine vita un minuscolo virus ha sbattuto in faccia lo sgomento di una morte solitaria, isolata, asettica.
A marzo 2020 restavamo annichiliti dal bollettino funereo diramato giornalmente dalla Protezione Civile mentre, a un anno di distanza, ci siamo quasi abituati alla conta dei morti, numeri a tre cifre che vengono letti come le previsioni meteo, quotidianamente. Come Antigoni moderne, chi ha vissuto queste perdite in prima persona, invece, ha subito un trauma ancora vivo per l’impossibilità di seppellire decorosamente i proprio cari, dovendosi accontentare, quando possibile, di frettolose cerimonie funebri scandite da regole volte ad arginare un ulteriore contagio, possibile causa di altre malattie e di altre morti.
È venuta inoltre a mancare la possibilità di riconciliazione che la contingenza ultima della vita di una persona spesso offre, l’occasione di pronunciare parole importanti, spesso decisive per la successiva elaborazione e accettazione del dolore. Si è venuto quindi a creare, in modo subdolo e ineluttabile, un lutto nel lutto.
La dottoressa Marina Sozzi, attualmente coordinatrice del Centro di Promozione Cure Palliative presso la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e autrice di tre volumi sulla morte e la malattia, ci ha accompagnati in una sentita riflessione, partendo dal chiedersi con quale approccio alla perdita fisica siamo arrivati alla pandemia del 2020. Nell’ultimo secolo, infatti, la morte più che una rimozione (termine proprio della psicanalisi) o un tabù (termine che invece pesca nel sacro) è diventata all’interno della società un evitamento cosciente, con l’illusione di essersi liberati del memento mori grazie ai progressi della chirurgia e della medicina e di poter raggiungere la vecchiaia senza prima essersi occupati della morte. Similmente, anche le cerimonie si sono andate riducendo nella forma e nella durata così come le visite al cimitero, sempre più diradate per via della tendenza a preferire il ricordo del proprio caro in vita. Soprattutto ai non credenti i riti appaiono come ripetizioni di schemi prive di significato e, almeno per il momento in Italia, non esistono riti laici condivisi. In alcune situazioni estreme, gli stessi morenti sono lasciati soli per il rifiuto di interfacciarsi con la morte imminente, contrariamente a quanto introdotto dalle cure palliative nel nuovo secolo.
Con l’avvento del covid la società si è improvvisamente ritrovata a fare i conti con una angoscia di morte collettiva e quotidiana. Il grottesco slogan “Andrà tutto bene” e gli euforici canti dai balconi della prima ondata sono stati un iniziale tentativo di esorcizzare la situazione unitamente alla trasformazione dei sanitari in supereroi con mascherine sul viso al posto del mantello magico sulle spalle: è stata una reazione volta principalmente al non voler vedere lo spaesamento della medicina, la mancanza di una cura o di un antidoto efficaci e collaudati. Riassumendo all’osso, e forse banalizzando: tutti sappiamo che dovremo morire, in giorno, ma nessuno è disposto a farlo ora, qui, subito e si mettono di conseguenza in atto meccanismi di fuga dalla realtà.
L’emergenza ha purtroppo reso necessario e inevitabile accantonare l’approccio di accompagnamento delle cure palliative lasciando posto a morti solitarie – sia quelle da covid che non – ultimi saluti attraverso lo schermo pietoso di un telefonino e comunicazioni di decesso spesso affidate a personale non adeguatamente formato, soprattutto per farlo a distanza, a sua volta provato ed esausto da turni di lavoro estenuanti.
Soprattutto nella prima ondata c’è stata una totale mancanza del rito funebre, al massimo celebrato in modo frettoloso, senza contatto o possibilità di vedere un’ultima volta i propri cari, chiusi di fretta dentro bare anonime. Questo ci ha fatto comprendere come i funerali non siano in realtà pleonastici ma essenziali per elaborare il lutto perché concludono la serie di eventi che ha portato alla perdita ultima e permettono, quindi, un nuovo inizio. Il rito in sé offre l’occasione di esprimere e condividere le emozioni che si provano ed è un omaggio ai propri cari, aiuta a consolidare le reti familiari ed amicali ed è il primo passo per costruire la memoria di chi non c’è più. È una cerimonia che serve a chi resta, ma è consolatoria anche per chi è in procinto di andarsene, confidando di ricevere una degna sepoltura.
Storicamente, non è stata la prima volta nella storia che il rito funebre ha subito un accantonamento: si pensi alla peste del ‘600 e ai carri carichi di cadaveri descritti dal Manzoni attraverso gli occhi dei personaggi de I promessi sposi. Nel Settecento, invece, si era preso a seppellire i morti fuori dalle mura della città come soluzione ai miasmi maleodoranti che provenivano dai cadaveri e solo con Napoleone si iniziò a ripensare ad un’organizzazione regolamentata e strutturale del cimitero come luogo di culto.
In ogni caso, la de-ritualizzazione della morte origina un vero e proprio trauma, peggiorato dal senso di colpa di non avere nemmeno potuto assistere il malato, di non aver potuto “prendersi cura”. Oggi ci viene in soccorso la tecnologia, con la celebrazione digitale di funerali in streaming o via whatsapp, che con tutta probabilità resterà come metodologia parallela anche dopo la pandemia, per venire incontro alle esigenze di un mondo globalizzato dove tante persone si spostano e vivono fra più Paesi.
Il bisogno di commemorare i defunti ha determinato anche una notevole creatività rituale, per esempio a Torino la scorsa estate in un ospedale gli operatori hanno organizzato un rito funebre simbolico nel cortile della struttura, interrando e annaffiando degli alberelli e nominando tutti i defunti ad alta voce, raccontando brevemente le storie di vita di ciascuno. Sono sorti anche alcuni monumenti commemorativi della pandemia, il primo a Codogno, uno dei centri più colpiti della prima ondata, dove ora campeggia un monumento recante la scritta “Resilienza – Comunità – Ripartenza”. A Casal Pusterlengo, un architetto ha invece coinvolto la cittadinanza chiedendo di raccogliere delle pietre sulla riva del Po su cui scrivere i nomi dei cari scomparsi e una frase di commemorazione. Con queste pietre è stata poi costruita una torre nella piazza del paese dove poter esprimere il proprio cordoglio e riflettere su quanto è accaduto e sta, purtroppo, ancora accadendo.
Sono modi, semplici ma potenti, per ossigenare il lutto, per dirla con le parole dello psicologo Nicola Ferrari, ossia per farlo respirare a pieni polmoni, esprimere, assegnargli un posto.
Sarebbe auspicabile, quando consentito, organizzare una vera e propria cerimonia pubblica istituzionale, come quella di inumazione del milite ignoto dopo la prima guerra mondiale, dove scomparve una generazione di giovani sotto le bombe mentre, oggi, ne perdiamo una di anziani e dobbiamo preservare la memoria di quello che ci hanno lasciato. Si avverte quindi forte, prepotente, l’esigenza di ridare carne e sangue a questi morti, salvare la memoria delle loro vite mediante un processo sociale collettivo. In una parola, restituire dignità: a chi non c’è più e se ne è andato via sentendosi solo e vulnerabile, a chi è rimasto ma anche a chi si è speso e ha chiuso gli occhi di questi malati, con la paura del contagio e la stanchezza di un ruolo nuovo e provante.
Nel bene e nel male, la pandemia da Covid-19 lascerà inevitabilmente strascichi ma anche qualche lezione che, se si avrà l’umiltà di conservare, potrà aiutare a far ripartire una sanità e una società memori di quanto è stato.